Il gioco è alla base della crescita psicofisica dei mammiferi e di conseguenza anche di noi umani. Nel genere umano il gioco non serve solo durante la crescita ma continua a essere importante anche in età adulta.
Possiamo dividere i giochi in due grandi filoni: fisici e mentali.
I giochi fisici, spesso, si svolgono all’aperto o in grandi spazi al coperto. Negli anni si sono evoluti, dal semplice inseguimento e cattura o lotta, con azioni simili ai giochi dei cuccioli degli altri mammiferi, fino a complessi giochi di squadra.
I giochi mentali si sono sviluppati da semplici giochi di parole fino ad arrivare all’ enigmistica più complessa.
Dalla combinazione dei meccanismi delle due precedenti categorie, sono nati diversi giochi di società.
Nel tempo sono cambiati gli strumenti per giocare; ad esempio: le carte e gli scacchi sono stati sostituiti dalle immagini degli apparecchi digitali.
Se nei solitari c’è il tentativo di soddisfare la necessità di sconfiggere la noia, nei giochi di gruppo c’è il piacere di battere gli avversari in sfide, talvolta interminabili che soddisfano il nostro cervello affamato di dopamina.
Con l’arrivo e la diffusione più che capillare degli smartphones, posseduti ormai sia dagli adulti ma, purtroppo, anche da bimbi molto piccoli, nei giochi si è interposto questo medium che sembra indispensabile per svolgere qualsiasi attività. Lo smartphone si è appropriato delle nostre vite e del nostro tempo isolando, sempre più, l’individuo trasformato in spettatore solitario dei giochi. Talvolta il volersi cimentare nelle vesti di attore, può portare ad esiti anche catastrofici, come quando il giocatore si fa coinvolgere, per emulazione, in “Challenges” (sfide) di “coraggio” pericolose.
Torno a scrivere dei giochi senza più addentrarmi in temi sociologici se non per un esempio utile a proseguire il discorso iniziale.
Se mettessi in una stanza un piccolo gruppo di ragazzi adolescenti e chiedessi loro, dopo aver ritirato i loro smartphones: “ Bene, giocate liberamente per un’ oretta”.
Sono certo che mi guarderebbero sbigottiti e paralizzati non sapendo come passare il tempo in modo ludico.
Facciamo un salto indietro nel tempo, negli anni ’60. Le sfide avvenivano senza pericolo ma con un gran divertimento, utilizzando: qualità mentali come la memoria, l’arguzia e il coordinamento linguistico.
Da ragazzini, durante i mesi invernali, quando non potevamo giocare all’aperto, ci riunivamo a casa dell’uno o dell’altro e ci divertivamo con giochi mentali che non avevano bisogno di oggetti di intermediazione per scatenare il divertimento.
Come non ricordare, con piacere, le velocissime gare di Tabelline. Oggi non so se i ragazzi sono in grado di rispondere al volo alla domanda: quanto fa 6×7 e continuare se la risposta è corretta, e 8×8, finché l’interrogato non sbaglia e tocca a lui interrogare. Altre gare erano basate sulla coniugazione dei verbi. Si univa così l’utile al dilettevole.
Altro gioco divertente che talvolta coinvolgeva anche gli adulti presenti in casa era risolvere gli indovinelli. Questi giochi necessitano di arguzia e l’uso del “pensiero laterale”.
Sono convinto che se chiedessi ai ragazzi ma, azzardando, anche agli adulti:
“Qual è quell’animale che al mattino si muove su quattro gambe a mezzogiorno su due e la sera su tre?”
Pochi, ma proprio pochi, saprebbero rispondere a questo antichissimo indovinello.
Ne cito un altro che riporto in italiano e non in dialetto per essere più facile da comprendere:
“Ha un’asta e un pendente
quando è moscia
non conta niente
indovina cos’è?”
Dopo che avrò svelato la soluzione dei due indovinelli, molti, si batteranno la mano sulla testa con una reazione tipica:
“ Ma come ho fatto a non pensarci?”
La soluzione del primo e forse più antico indovinello, infatti, è una versione del quesito posto dalla Sfinge a Edipo: L’uomo. Da bambino, durante il mattino della vita, si muove su quattro gambe gattonando; poi da adulto, il mezzogiorno della vita, si muove su due gambe e infine, la sera, da anziano si aiuta con il bastone.
La soluzione del secondo è ancora più intrigante perché qualcuno avrà pensato a qualcosa di malizioso, ma così non è. Il bello di alcuni indovinelli è di sviare dalla corretta soluzione; in questo caso l’uso del pensiero laterale è fondamentale.
L’ interpretazione corretta e la giusta risposta è:
La stadera, cioè la bilancia tipica degli ambulanti: quando è in posizione per pesare ha l’asta orizzontale su cui scorre il “romano” cioè il peso pendente; poi, quando è in posizione raccolta, non conta niente cioè non misura alcunché (niente).
Fine prima parte.
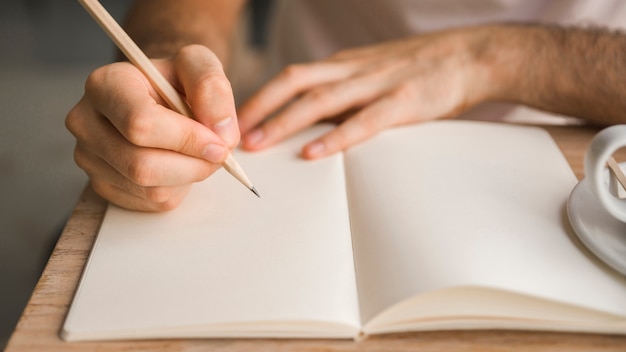


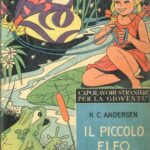

Lascia un commento